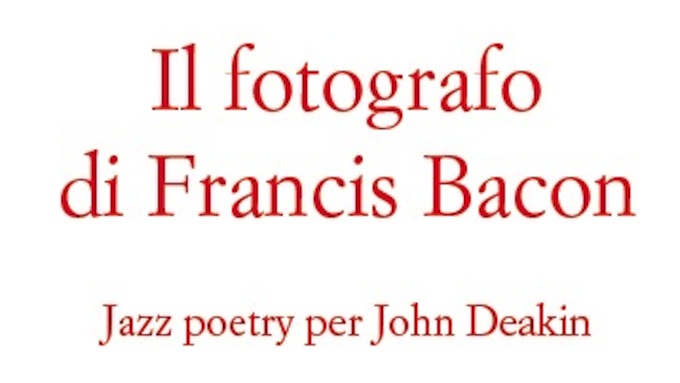Barbara Idda, Il fotografo di Francis Bacon, Edizioni ETS 2017, euro 10
“I miei modelli sono le mie vittime”, scrive John Deakin – e paragona il venire fotografati all’essere esposti a un sacrificio. Probabilmente il sacrificio al quale si riferisce Deakin è l’ostensione di sé, la definitiva mancanza di segretezza, la trasparenza alla quale la fotografia ci assoggetta.
Per scrivere di questo “cattivo ragazzo”, che è riuscito a rovinare la propria collaborazione con la rivista “Vogue” perché il suo talento non era accompagnato da un’altrettanto grande capacità di gestirlo nel mondo della così detta “realtà”, Barbara Idda ha operato una mimesi con l’anima di Deakin e dei suoi compagni, si è addentrata nella Londra della fine degli anni Cinquanta, fino a identificarsi con Deakin e suoi amici pittori Lucian Freud e Francis Bacon, presentandoci un discorso diretto tra loro, un dialogo dal piglio dichiaratamente orale, ritmico, spesso circolare – con un coro a fare da contrappunto. Si tratta dunque di poesia di impianto tragico, scritta per essere detta.
Verso l’inizio della jam session troviamo la bellissima confessione di Francis Bacon, il pittore che adoperò gli scatti di Deakin per i propri quadri: “Ho preso le sue foto / le ho usate / e quando le ho restituite / non erano più le stesse / non erano più sue / ed erano diventate niente. […] perché tutto è nel quadro / più sangue luce senso”. Dunque si tratta del furto di un furto: Deakin preda l’anima delle persone e Bacon preda le immagini che Deakin raccoglie dal mondo e le addiziona con qualcosa che però, a sua volta, le leva dal mondo reale e da quello interiore dell’amico fotografo. Un mondo che rimane dunque doppiamente estraneo alla bolla di solitudine di Deakin, una società fatta di estranei che non lo accompagnano nel suo sghembo cammino, ma che gli diventano magneticamente vicini solo nell’istante del lampo fotografico.
Del resto, è detto: il peccato è “restare / quando dovresti andartene” – e dunque la straziata conseguenza non può che essere un’affermazione come “sono abbastanza buono / adesso che non ho più nulla”.
Tutto il testo di Barbara Idda mette in scena una perdita già avvenuta: qualcosa è già stato mancato o si è sottratto prima dell’apertura – della pagina o della scena, è sottintesa una perdita originaria alla quale tutti i protagonisti sopravvivono senza cercare di riempire il vuoto con altro che con il vuoto: l’esortazione a toccarsi senza fidarsi è infatti il contrario di quanto suggerisce l’altro grande autore, britannico e contemporaneo di Deakin e Bacon, Philip Larkin, quando scrive “Dovremmo essere gentili / finché siamo in tempo”: la jazz poetry di Idda è condotta all’insegna di una verità affidata al corpo. Sembra infatti che ci si possa fidare solo del corpo, del contatto tra corpi, che a volte però rendono più viva la solitudine, “se ti stringo / come non avessi nulla tra le braccia / quando c’è stato un tempo / in cui eri così tanto / come avessi tutto tra le braccia”.
La perdita è avvenuta perché è finito l’amore che si prova, non quello che si riceve.
Credo che i due versi cardinali del libro siano “non posso più averti / perché non ti amo più”. E credo che questo valga pure per il mondo nel quale Deakin si muove, non solo per la sua relazione amorosa con Uomo: un mondo acido, ustionato dalla perdita che consegue al disamore. Ecco allora confermata la necessità della gentilezza sostenuta da Larkin. La sola vittoria sulla solitudine è amare. Ovunque, pure in questa Londra di bar notturni e di eleganza contraddetta dall’incuria, pure davanti al portone di una casa dove un tempo vivemmo felici. Ma “non si può mai entrare / dove vorremmo”, scrive Idda, ricordando Kafka. Chissà se perché, riuscendo nei nostri intenti, smetteremmo di essere mossi dall’energia propulsiva del desiderio e dunque ci tendiamo continue trappole di fallimento, manchiamo il nostro bersaglio per continuare ad avere un bersaglio – o se, più probabilmente in questo contesto emotivo, l’infelice è infelice perché non sa cosa davvero desidera, è uno dei molti uomini accompagnati dallo Stalker di Andrej Tarkovskij nella Stanza-mondo, dove si entra desiderando ardentemente una cosa e si esce avendone ottenuta un’altra. Diversissima.