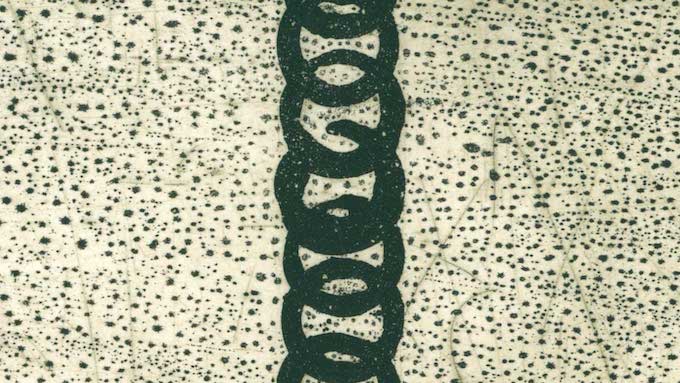Haroldo Conti, Sudeste, Exorma 2018, pag. 217, €14,90
Dopo cento lentissime pagine di bravura smisurata nel descrivere il rapporto simbiotico tra il Boga, un tagliatore di giunchi «con gli occhi da pesce moribondo», e la foce del fiume Paranà, Haroldo Conti improvvisamente ti afferra alla gola e ti inchioda a una vertiginosa epifania del senso di ogni cosa.
Tremano le mani a scriverne, anche perché pensi alla fine dello scrittore argentino e torna a risuonare quella parola che a lungo nella nostra infanzia per noi degli anni Settanta è stata allo stesso tempo lontana e quotidiana, macabra e non comprensibile fino in fondo: desaparecido. E a quello non puoi non pensare se pensi ad Haroldo Conti, una delle 40.000 vittime del mostruoso regime del generale Videla, sequestrato nella sua abitazione la notte del 5 maggio 1976, al ritorno da una serata al cinema con la moglie Marta Scavac, sfuggita miracolosamente al sequestro insieme ai due piccoli figli (Ernesto era nato a febbraio) perché nella macchina dei sequestratori non c’era posto per tutti in solo viaggio.
Leggendo il libro, sapendo questo, e altro, della vicenda umana di Conti, ma non avendo mai letto niente prima (finora Conti aveva conosciuto una sola traduzione italiana nel 1983, del romanzo Mascarò, il cacciatore americano, ormai introvabile), non può uscirti dalla testa la sensazione che qualcosa non torni, anche considerando la logica, distorta, del cosiddetto “processo di riorganizzazione nazionale”. Cosa ha a che vedere, pensi per oltre cento pagine, questo splendido e pacifico racconto di un allontanamento dai dissidi umani, con il profilo di uno scrittore dichiarato sovversivo e sulle cui tracce i battaglioni della morte erano già da mesi?
Sembra un libro di totale disimpegno, Sudeste.
Morto il Vecchio, con cui lavorava, il Boga lascia ogni cosa, monta su una piccola e precaria imbarcazione e si consegna al fiume. Da quel momento in poi la sua storia pare quella di un lento, lentissimo abbandono al fluire della vita del Paranà tra i suoi vari affluenti, isolette e paludi del delta del fiume. La vita è il fiume. Il fiume è la vita. Non c’è altro. Nessuna volontà in atto, nessuna resistenza alle correnti del destino.
Non accade niente ma ogni istante si accende di unicità per la sensibilità con cui Conti declina la sua scrittura per variazioni infinitesimali. In uno spazio grande un pugno di miglia, di ora in ora, variano i venti, e i loro nomi, i pesci, e i loro nomi, gli alberi, e i loro nomi, il volo diverso di mille specie diverse di uccelli, anch’essi ognuno col loro nome, e questa nomenclatura esotica, scandita col ritmo dei remi che accarezzano e feriscono le acque, sembra voler restituire sulla carta anche l’unicità del panorama sonoro della foce. Le parole stesse diventano fiume. E ancora variano da un attimo all’altro le correnti, l’incresparsi della superficie del fiume, la luce, i profumi. È bravissimo il traduttore Marino Magliani nel restituire in italiano questo spartito. Con quanta poesia, una poesia umile come il suo protagonista, si scivola placidamente nella contemplazione e oltre! Quasi una mistica annichilatio.
Il fiume è la vita, e il suo mistero. Il fiume è splendido e l’uomo se ne sente misteriosamente attratto Questo è tutto ciò che si può dire. E ancora: Il fiume è molto grande, e uno non può sapere tutto quel che fa il fiume. All’umile pescatore di giunchi sembra sovrapporsi progressivamente un’identità da monaco zen. Abbandonarsi al fiume è un gesto di natura iniziatica. La metafora fiume/vita si fa onnicomprensiva e, senza esondare nell’allegorico, grazie a un realismo a livello di guardia altissimo, accende ogni pagina con una forza simbolica sempre maggiore. Viene esplicitamente declinata all’interno della metafora del fiume perfino una distinzione tra la vita intesa come zoé (la vita come principio universale) e la vita intesa come bíos (le singole vite), la collana e le perle della collana. Sono categorie familiari a Haroldo Conti, cresciuto con una solida formazione filosofica e teologica. E loro stettero lì, attorno al fuoco, ciascuno con la sua storia, come due fiumi che dopo lunghi percorsi hanno appena riunito le loro acqua e adesso corrono verso il fiume aperto, spinti da una stessa forza, cieca e oscura.
Ma ecco che tra un quasi nulla e l’altro si moltiplicano misteriosi segni e presentimenti che instillano goccia a goccia nel Boga un turbamento sempre meno lieve: gli esiti del tentato furto di un’anatra, l’incontro con un omino che assomiglia a un conoscente scomparso, il ritrovamento della carcassa di uno yacht… Finché dalle miti correnti della vita e del fiume erompe in tutta la sua potenza una forza irrazionale.
Il Boga aveva avvertito qualcosa di malvagio nel fiume. Che di solito è indifferente, ma a volte diventa incredibilmente malvagio. […] Era qualcosa che sta in fondo all’anima di questo fiume, che trascina tonnellate di fango. Una forza che sta nel vecchio e nel cane baio […] e cioè nel fiume e in tutto ciò che lo riguarda, in tutto ciò che in qualche modo è fiume. E quindi era in lui. Anche in lui. Era l’altra metà dell’essere umano, o meglio, la più intima essenza dell’uomo, l’elemento cieco e incontrollabile […].
Abbandonarsi alla realtà è abbandonarsi a tutte le sue forze, nessuna esclusa. L’epifania è sconvolgente. Nell’abbandonarsi al fiume della vita, ci eravamo sbagliati, come il Boga. Quello che sembrava un mistico romanzo sul nulla, è invece un potente romanzo sul Male. Quel Male che, come direbbe Gadda, «affiora a schegge, imprevisto, orribili schegge da sotto il tegumento». Il Boga, e con lui il romanzo, vengono trascinati in una spirale di violenza e tensione. Lo scrittore stesso sembra in balia di una forza, quella della visione, che lo scaraventa dalla contemplazione a una sorta di trance in cui scrive quella che ha tutta l’aria di essere una precocissima autoprofezia. È il destino degli scrittori che vedono dentro le cose.
Il Male, la Storia ce lo insegna, è sempre in agguato nell’ombra, nelle profondità dell’umano, pronto a saltare fuori e imporre la sua forza. Per il Boga era nascosto dentro la carcassa di una barca. Quello di Conti era nascosto dietro la porta di casa, la notte del 5 maggio 1976. Gli amici lo avevano avvertito più volte, cercando di convincerlo a riparare all’estero. Lui aveva risposto: «Questo è il mio posto di combattimento. Da qui non me ne vado». Era un hombre vertical che combatteva con le armi della bellezza. Continuano a combattere per lui i suoi libri, come questo capolavoro, capace di stregarci, di toccarci, di emozionarci, di scuoterci e di insegnarci a non abbassare mai la guardia.